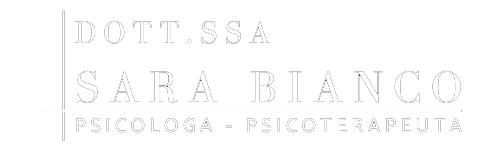Psicoterapia nei Disturbi Alimentari
I DISTURBI ALIMENTARI: CHE COSA SONO? I Disturbi Alimentari sono psicopatologie complesse che possono esprimersi in forme articolate investendo il corpo e la mente della persona. Le caratteristiche si…
Scopri di più